|
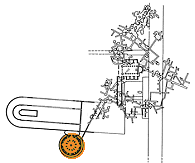
|
“Il Santo Concilio comanda ai vescovi e a coloro che hanno la
funzione e l'incarico di insegnare [...] di istruire con cura i fedeli
sugli onori dovuti alle reliquie [...], mostrando loro che i corpi santi
dei martiri e degli altri santi, che vivono con il Cristo e che furono
membra viventi di Cristo e tempio dello Spirito Santo [...], attraverso
cui benefici numerosi sono accordati da Dio agli uomini, devono essere
venerati dai fedeli”.
 I
decreti del Concilio di Trento 984 e 985, che fissano le linee
di fondo della dottrina cattolica sulle reliquie, rappresentano il punto
di arrivo di un processo, che affonda le sue radici nella pietas
dei primi cristiani verso il corpo dei martiri. Essa riflette, almeno
alle origini, non tanto il culto riservato dal mondo grecoromano agli
eroi-culto che, al tempo in cui apparve il cristianesimo, mal si distingueva
da quello riservato agli dèi -, quanto piuttosto gli usi funerari
normali. Essi consideravano la sepoltura, la cura del corpo del defunto,
le feste commemorative della morte, come doveri sacri; leggi rigorose
proteggevano il luogo della sepoltura come luogo sacro, ne vietavano la
profanazione e impedivano lo spostamento del corpo. L'importanza che il
martirio assunse nella teologia, nell'apologetica, nella vita dei cristiani
dei primi tre secoli sviluppò un vero culto dei martiri e delle
loro reliquie, di cui il documento più antico è ìl
Martyrtum Policarpi. I
decreti del Concilio di Trento 984 e 985, che fissano le linee
di fondo della dottrina cattolica sulle reliquie, rappresentano il punto
di arrivo di un processo, che affonda le sue radici nella pietas
dei primi cristiani verso il corpo dei martiri. Essa riflette, almeno
alle origini, non tanto il culto riservato dal mondo grecoromano agli
eroi-culto che, al tempo in cui apparve il cristianesimo, mal si distingueva
da quello riservato agli dèi -, quanto piuttosto gli usi funerari
normali. Essi consideravano la sepoltura, la cura del corpo del defunto,
le feste commemorative della morte, come doveri sacri; leggi rigorose
proteggevano il luogo della sepoltura come luogo sacro, ne vietavano la
profanazione e impedivano lo spostamento del corpo. L'importanza che il
martirio assunse nella teologia, nell'apologetica, nella vita dei cristiani
dei primi tre secoli sviluppò un vero culto dei martiri e delle
loro reliquie, di cui il documento più antico è ìl
Martyrtum Policarpi.
Nel culto delle reliquie - soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi
successivi al III sec. - confluisce, accanto alla pietas funeraria
amplificata dalle dottrine relative al martirio e alla santità,
anche l'idea che la potenza salvifica degli uomini di Dio sia un qualche
cosa di fisico, che rimane inerente al corpo, vivo o morto, del santo,
e che, da questo, possa trasmettersi agli oggetti che, in forme più
o meno dirette, ne sono venuti in contatto. È una concezione molto
antica, che si trova nella tradizione giudaico-cristiana (ad esempio,
in 4 Re, 2,14, il prodigio operato dal mantello di Elia, ripreso
dal miracolo evangelico dell'emorroissa. In Luca, 8, 46, Gesù
dice: “Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è
uscita da me”), ma che è precedente ad essa e riflette una
concezione magica delle reliquie.
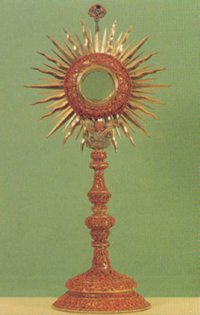 Se,
da un punto di vista dottrinale, i pronunciamenti ufficiali della
chiesa non hanno mai cessato di insistere sul fatto che il culto reso
ai santi consiste in onori riservati a uomini di cui si vuole celebrare
la particolare unione con Cristo, e che i miracoli sono compiuti non dalle
reliquie, ma da Dio attraverso di esse, tuttavia, a partire
dal IV sec., i comportamenti concreti e generalizzati, che portarono a
uno sviluppo abnorme ed incontrollabile delle reliquie, sembrano
piuttosto allinearsi con la concezione poco sopra esposta. Se,
da un punto di vista dottrinale, i pronunciamenti ufficiali della
chiesa non hanno mai cessato di insistere sul fatto che il culto reso
ai santi consiste in onori riservati a uomini di cui si vuole celebrare
la particolare unione con Cristo, e che i miracoli sono compiuti non dalle
reliquie, ma da Dio attraverso di esse, tuttavia, a partire
dal IV sec., i comportamenti concreti e generalizzati, che portarono a
uno sviluppo abnorme ed incontrollabile delle reliquie, sembrano
piuttosto allinearsi con la concezione poco sopra esposta.
Se le sedi di più antica cristianizzazione disponevano di numerose
ed autentiche reliquie dei martiri, le nuove sedi (ad esempio Costantinopoli)
le ottennero mediante traslazioni o smembramenti dei corpi, secondo
un uso proibito dalle leggi imperiali (Codice Teodosiano, IX, xvn) - che
fu prevalentemente orientale fino all'VIII sec. per divenire in seguito
generalizzato.
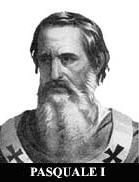 Nel
IX sec. troviamo un papa, Pasquale
I (817-824), che fa spostare dentro Roma duemilatrecento corpi, che
distribuisce fra le diverse basiliche. L'idea che il possesso del corpo
di un santo costituisse, per la città, il villaggio, la basilica,
un presidio insostituibile contro le malattie, le calamità,
i disastri di ogni genere, i disordini, l'eresia e fosse un elemento insostituibile
per la promozione e la fama di un luogo di culto, moltiplicò le
inventiones di corpi attribuiti ai santi, nella maggior
parte dei casi, sulla base di indicazioni derivanti da sogni, visioni
o altri tipi di segni (ad esempio il profumo) miracolistici. Talora l'ansia
di possedere il corpo di un santo diede luogo a contese ed a furti
veri e propri. Nel
IX sec. troviamo un papa, Pasquale
I (817-824), che fa spostare dentro Roma duemilatrecento corpi, che
distribuisce fra le diverse basiliche. L'idea che il possesso del corpo
di un santo costituisse, per la città, il villaggio, la basilica,
un presidio insostituibile contro le malattie, le calamità,
i disastri di ogni genere, i disordini, l'eresia e fosse un elemento insostituibile
per la promozione e la fama di un luogo di culto, moltiplicò le
inventiones di corpi attribuiti ai santi, nella maggior
parte dei casi, sulla base di indicazioni derivanti da sogni, visioni
o altri tipi di segni (ad esempio il profumo) miracolistici. Talora l'ansia
di possedere il corpo di un santo diede luogo a contese ed a furti
veri e propri.
Tra il VI e il VII sec., soprattutto in Gallia e nell'Italia settentrionale,
si sviluppò il culto delle reliquie di contatto: gli abiti
del santo, gli strumenti che ha usato, ma anche la pol vere grattata dal
suo sepolcro, perfino l'olio della lampada che lo rischiara.
La conquista della Terrasanta (1204) aumentò ulteriormente
la massa delle reliquie, facilitandone gli abusi: la compravendita
di reliquie, la loro falsificazione, l'esistenza di reliquie multiple
 (ad
esempio le diverse teste di Giovanni Battista, di cui una si troverebbe
a Roma, un'altra in Francia, un'altra ancora a Damasco, meta dio pellegrinaggi
musulmani). Abusi che, periodicamente, hanno suscitato critiche al culto
delle reliquie, considerato dai suoi detrattori, interni (la prima documentata
è quella del prete di Tolosa, Vigilantio, anno 403) ed esterni,
come espressione di idolatria pagana e di sciocca superstizione. (ad
esempio le diverse teste di Giovanni Battista, di cui una si troverebbe
a Roma, un'altra in Francia, un'altra ancora a Damasco, meta dio pellegrinaggi
musulmani). Abusi che, periodicamente, hanno suscitato critiche al culto
delle reliquie, considerato dai suoi detrattori, interni (la prima documentata
è quella del prete di Tolosa, Vigilantio, anno 403) ed esterni,
come espressione di idolatria pagana e di sciocca superstizione.
Il testo, cui sono stati aggiunti i neretti e le interruzioni di paragrafo,
è tratto dal Dizionario delle religioni, Einaudi, Torino, 1993

|
|



